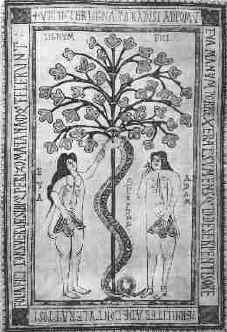
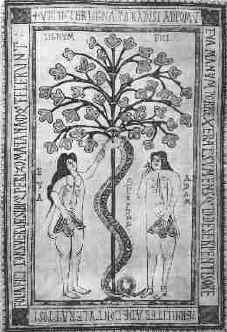
![]()
L’IMMAGINE E L’ICONA
All’inizio del secolo, la famosa affermazione di Freud “l’Io non è padrone in casa propria”, riapre un capitolo che pareva definitivamente chiuso nella storia evolutiva del soggetto occidentale.
Fino a quel momento, infatti, sembrava che prima il “cogito” cartesiano, poi il secolo dei lumi, avessero liberato una volta per tutte l’uomo dalla dipendenza da dogmi metafisici e dalla prigionia di un determinismo che limitava la libertà e l’autonomia del soggetto. Non più “figlio del Padre”, costretto “a sua immagine e somiglianza”, l’uomo dell’età moderna aveva rotto risolutamente le catene che lo legavano ad una struttura opprimente e finalmente padrone di sé stesso e del proprio avvenire, aveva costruito autonomamente la propria identità, fondandola su nuove basi razionali e materiali, cioè “visibili” e “tangibi-li”. Ed invece, proprio nel pieno affermarsi e consolidarsi del processo di secolarizzazione nella società occidentale, la proposizione freudiana spalanca al soggetto l’enormità di un abisso interiore a lui sconosciuto, nelle cui profondità si agitano forze di grande potenza, alla cui dispotica influenza l’Io, ignaro, soggiace. Una nuova potenza, anch’essa “invisibile”, che esercita la propria forza condizionante appunto perché nascosta, in ombra, celata alla vista di un Io “cieco”, inconscio di una estesa parte di se stesso. Il soggetto, che si credeva libero da ogni dipendenza esterna e trascendente, scopre una nuova forma di dipendenza, questa volta interna.
“L’Io non è padrone in casa propria”.Non è padrone, dice Freud, perché ha “rimosso” componenti sgradite ma essenziali della personalità, le quali allora esercitano il loro potere dal territorio oscuro dell’Es, cioè fuori dalla vista e dal controllo dell’Io.
L’avere individuato nella rimozione, nella “cecità” dell’Io, la causa principale della genesi di questo stato conflittuale della personalità condusse all’elaborazione di un metodo, quello psicoanalitico appunto, che, attraverso l’“integrazione” alla coscienza dei contenuti inconsci, consentisse di restituire al soggetto la sua libertà e autonomia. “Ove era l’Es, ivi sarà l’Io”, è un’altra proposizione freudiana che sintetizza l’orientamento della metodologia psicanalitica la quale si proponeva, attraverso l’elaborazione e la comprensione del linguaggio “simbolico” delle manifestazioni psichiche inconsce, di “illuminare” porzioni sempre più vaste dell’Es aggregandone i contenuti al campo visibile della coscienza, fino ad esautorare la zona d’ombra. Un primo, potremmo dire, titanico ma ingenuo compito, ben presto sostituito dal progetto, più realistico e corretto, di ristabilire un rapporto dinamico di scambio, fra la coscienza e l’inconscio, che almeno ne riducesse la contrapposizione e consentisse un certo dialogo fra le parti.
In tutti i casi la condizione preliminare, comune alla tendenza analitica generale, consisteva e consiste nell’“illuminare” l’ombra, rendere visibile l’invisibile, conscio ciò che è inconscio, svelare il mistero celato all’interno del soggetto, ancora una volta turbato dall’esistenza e dalle manifestazioni di qualcosa che lo trascende e che sfugge al suo controllo.
In questo processo di svelamento, che si attua attraverso l’esame e l’elaborazione dei prodotti dell’attività inconscia, acquistano un rilievo particolare le “immagini” psichiche. Il lavoro analitico si gioca tutto attorno all’immagine; è attraverso la comprensione del linguaggio “oscuro” dell’immagine che il soggetto può entrare in rapporto diretto con i contenuti potenziali della psiche inconscia che si manifestano con immagini, oniriche, fantastiche, o gestuali che siano.
Per Jung, “l’immagine è psiche”, tout court. Intendendo sottolineare con questa affermazione l’importanza vitale dell’attività immaginativa, cioè della “funzione simbolica dell’inconscio”, che per Jung non riveste affatto un carattere meramente “poetico” o astratto, cioè importante ma tutto sommato marginale per l’economia globale dell’individuo. Al contrario, la “funzione simbolica”, in quanto principale espressione dell’attività “creativa” rappresenta una funzione fondamentale per il soggetto proprio nell’estrema concretezza del suo processo di adattamento alla realtà.
Questo, com’è noto, è un punto cruciale della ricerca di Jung: per lui l’inconscio non è solo la terra di esilio di contenuti inadeguati e di residui pulsionionali obsoleti e ormai incompatibili, bensì è la fonte primaria, la “madre” delle energie e il luogo transpersonale dove si svolgono quei processi di trasformazione creativa che consentono all’individuo di “trascendere” i limiti del proprio Io ed arricchire la personalità di modalità inedite adeguate a fronteggiare le mutevoli esigenze della realtà.
La “funzione trascendente” della psiche, come la definisce Jung, è la facoltà creativa transpersonale dell’individuo, rappresenta cioè la sua capacità di elaborazione creativa in un processo di trasformazione che coinvolge tutto il suo essere, sia conscio che inconscio, e si esprime attraverso le immagini.
L’inconscio non è solo un “perturbante” da ricondurre alla normalità o una scomoda presenza con la quale addivenire a compromessi più o meno soddisfacenti, bensì, nella prospettiva junghiana, quella parte dell’individuo che contiene in sé le potenzialità e le possibilità di sviluppo della personalità. In assenza di una adeguata correlazione fra l’Io e l’inconscio non è possibile, per Jung, nessuna vera trasformazione della personalità, nessuna “crescita” individuale e collettiva. L’Io scisso dalle sua radici inconsce è incapace di autentici rinnovamenti, è in grado solo di replicare con varianti puramente meccaniche la struttura già esistente.
L’immagine simbolica quindi non è mero “segno”, segnale che sta al posto di un altro significato rimosso ma già esistente; il “simbolo” è, per Jung, la migliore forma di espressione di qualcosa la cui complessità è tale da non poter essere interamente e immediatamente afferrata dalla coscienza; l’immagine simbolica è la migliore forma possibile di rappresentazione attraverso la quale un “tutto” si manifesta e può quindi essere percepito, intuito, ma non compreso fino in fondo da quella “parte del tutto” che è l’Io, la componente conscia della psiche.
In questa prospettiva cambia radicalmente anche il modo di porsi nei confronti delle immagini, le quali non vengono più semplicemente ridotte ad una presunta logica nascosta, celata sotto le mentite spoglie, ad esempio, dell’immagine onirica. Per Jung le immagini sono un punto di partenza e non di arrivo, e vanno semmai elaborate nel senso dell’“amplificazione” dei possibili significati che suscitano nel soggetto, senza uccidere la loro vitalità attraverso l’interpretazione, cioè astenendosi dal risolvere il mistero che le accompagna.
La psicologia archetipica di Hillmann radicalizza ancor più questo aspetto della metodologia junghiana: le immagini “... sono la psiche stessa nella sua visibilità immaginativa; in quanto dato primario, l’immagine è irriducibile.”
L’atteggiamento dell’Io deve quindi tendere ad “aderire” il più possibile all’immagine così com’è, senza alterarne i termini, neppure nel senso dell’amplificazione che rappresenta comunque un tentativo di concettualizzazione del simbolo. Per Hillmann, un vero incontro fra la coscienza e l’inconscio non può avvenire che attraverso la partecipazione attiva dell’Io alla “messa in scena” dell’immagine; l’“Io immaginale” hillmaniano si muove come “uno”, non l’unico né il protagonista, degli attori sulla scena della psiche, ed il suo compito non è diverso da quello svolto dalle altre istanze psichiche, cioè immaginare creativamente, “foggiare immagini”, “fare anima”. “Fare anima” non significa affatto rifugiarsi in un astratto fantasticare, al contrario radicarsi nel mondo e assumere le cose del mondo in quanto “valle dell’anima”, luogo del “fare anima”, cioè della realizzazione dell’imma-ginare attraverso attività concrete; realizzazione peraltro indissolubilmente legata alla visione “immaginale” del mondo, una visione cioè che “deletteralizzi” la realtà, che veda in “trasparenza” oltre il livello puramente esteriore della realtà, alla ricerca dell’“anima mundi”, di ciò che le cose hanno da dire alla nostra anima.
Sia in Jung che in Hillmann è comunque fondamentale il riconoscimento delle qualità creative e transpersonali dei processi inconsci, qualità determinate soprattutto dalla capacità di trascendere i limiti dell’Io; il soggetto, acquisita la consapevolezza di una tale presenza non può più ignorarla e di conseguenza è chiamato, se vuole trasformare la propria situazione conflittuale, a cambiare il punto di vista, e a rivolgersi verso i processi interiori e le manifestazioni della psiche con un atteggiamento che ambedue gli autori non esitano a definire “religioso”: per Jung “... nessuno “guarisce” veramente se non raggiunge un atteggiamento religioso...”, cioè quel rispetto e quell’“... osservanza accurata e scrupolosa ...” che è dovuta a qualcuno o qualcosa, un’energia, una potenza, che viene percepita come attiva e autonoma, transpersonale, indipendente dalla volontà del soggetto, il quale inoltre riconosce in essa il proprio fondamento, la propria origine vitale.
Per Jung, lo sradicamento dell’Io dalla propria base pulsionale, la scissione dalla matrice psichica, si è verificata ad un certo momento del lungo e graduale processo di differenziazione della coscienza dall’originario magma caotico e indifferenziato delle immagini dell’inconscio: la coscienza individuale e l’Io che ne rappresenta il nucleo centrale si è costituita, secondo Jung, attraverso un lento e progressivo processo di “differenziazione”, con la costituzione, in illo tempore, di un primo labile “campo” cosciente, cioè una zona della psiche dentro la quale alcune immagini riuscivano a mantenere una certa continuità.
Col passare del tempo questa zona si è allargata e consolidata diversificandosi sempre più nettamente dalla incessante sarabanda delle mutazioni, ma ad un certo punto, che Jung indica coincidere col periodo illuministico, l’autonomia dell’Io è diventata tale da fargli recidere o meglio da fargli disconoscere il legame libidico con l’inconscio, dichiararsi l’unico creatore di se stesso e intraprendere risolutamente la direzione verticale ipertrofica, negando la “madre” e, come abbiamo visto all’inizio, liberandosi allo stesso tempo dal giogo del padre. Rimozione del padre, cioè occultamento e quindi “cecità”; l’ipertrofia rende l’Io cieco e parziale, ne accentua gli atteggiamenti “miopi”, specialistici, provocando il ricorso a strumenti di ingrandimento sempre più potenti e perciò parcellizzati, riducendo nel contempo drasticamente la capacità di visione globale. Vengono a mancare il “senso”, l’orientamento del procedere e la percezione di “appartenenza”, di essere parte armonica di qualcosa di più grande, di avere uno scopo, un progetto che non sia solo contingente.
Potremmo dire che lo sviluppo ipertrofico dell’Io nella società occidentale, somiglia molto a quello di un adolescente che rimane “fissato” alla prima, peraltro necessaria fase conflittuale con i genitori e, invece di procedere oltre verso una vera autonomia con la creazione di una inedita immagine di sé, continua a definire la propria identità solo per contrapposizione, “contro” la propria tradizione, rimanendo senza saperlo ancor più dipendente di prima.
Incapace di vera autonomia, l’Io ipertrofico non riesce a sopportare il peso dell’angoscia esistenziale e, avendo rescisso le proprie radici, non può ricorrere né all’eros della madre, né alla tutela del padre. Se i figli dell’orda primitiva, nella famosa immagine freudiana, furono costretti ad abreagire il senso di colpa per l’uccisione del padre-despota ricorrendo alla ritualizzazione, così il soggetto della società occidentale secolarizzata tenta di sopperire all’angoscia del proprio sradicamento con un continuo acting-out, tentando cioè ossessivamente di restaurare nell’oggetto, cioè fuori di sé, quella solidità e quella sicurezza, quegli “assoluti”, che non riesce a ritrovare al proprio interno.
Indubbiamente la ricerca e la pratica psicanalitica in generale, sottraendo l’Io al suo isolamento, ripristinando il collegamento con l’inconscio e restituendo al soggetto gli strumenti simbolici necessari alla comunicazione con le istanze della psiche, hanno portato (naturalmente nei limiti del loro limitato campo d’azione) un contributo essenziale per la trasformazione di un orientamento responsabile di enormi danni per la salute psichica individuale e collettiva.
Ma riguardo alla duplice rimozione di madre e di padre di cui abbiamo parlato, potremmo dire che la psicologia analitica e la psicologia archetipica hanno agevolato principalmente la “riconciliazione” con l’universo simbolico della madre, fermandosi, per così dire, sulla soglia di quello paterno, penalizzato forse dal carattere “maschile”, principale imputato proprio dello sviluppo unilaterale dell’occidente. È evidente infatti, che se il primo passo per avviarsi sul cammino dell’individuazione consiste nell’accorgersi della presenza di un abisso interiore, il secondo è sicuramente quello di liberare l’“anima” che in quell’abisso era stata imprigionata, di permettere all’anelito dell’eros e al suo infinito desiderio di unione di fluire liberamente e permeare di rinnovata energia le cose del mondo, inaridite dall’atteggiamento unilaterale dell’Io. Il recupero dell’universo simbolico materno e la liberazione dell’anima consentono all’individuo di sperimentare tutta la potenza salutare del simbolo che raggiunge la sua più alta espressione creativa nelle “immagini” delle arti e dell’estetica. Jung e Hillmann non oltrepassano i confini di una visione antropologica della psiche, visione oltremodo vasta e salutare ma iscritta comunque all’interno di un orizzonte di finitudine. Per riproporre ancora la metafora genitoriale, potremmo dire che siamo tornati alla madre, ma non ancora al padre. Dice Armido Rizzi: “Se l’uomo fosse – e fosse soltanto – l’intreccio di natura e cultura che vive nel perimetro di corpo e linguaggio, allora il simbolo potrebbe esserne l’espressione radicale e insieme suprema, genesi e finalità, origine e compimento. Ma se dentro quel perimetro è piantato un centro che ad esso non appartiene, se sul corpo e sul linguaggio è issato un “cuore” – in quell’accezione biblica che vi ravvisa la libertà come decisione per il bene – allora l’uomo trascende il simbolo, non può essere ultimativamente definito come animale simbolico, né trovare nel simbolo la propria definitiva verità esistenziale. (...) Il simbolo è come l’humus della libertà: sua condizione di base, non sua essenza”.
L’uomo trascende il simbolo: certo non l’Io, ma neppure l’antrophos, che è contenuto dal simbolo. Esiste una ulteriore possibilità di trasformazione verso l’autonomia, per l’individuo che abbia recuperato pienamente il rapporto con l’anima, possibilità che Armido Rizzi definisce “passaggio dal desiderio alla realtà”, e che noi potremmo chiamare anche “passaggio dalla vista alla visione” o, appunto, “dall’immagine all’icona”. Abbiamo descritto l’Io ipertrofico impegnato nel vano tentativo di compensare l’angoscia esistenziale, causata dal suo sradicamento, attraverso la restaurazione ossessiva di “assoluti” nell’oggetto, sintomo evidente dell’incapacità di sopportare l’assenza di quello stesso assoluto precedentemente rimosso perché castrante, cioè il padre. L’Io ipertrofico è come un adolescente che rivendica a gran voce la propria autonomia ed è invece assolutamente incapace di stare da solo. È un figliol prodigo mancato che non ha il coraggio di sacrificarsi, di sacrificare il falso orgoglio e quindi non può tornare dal padre (che naturalmente non significa regredire ad una condizione subalterna, ma al contrario ritrovare dentro di sé il proprio senso di “appartenenza”, il proprio essere re-sponsabili di se stessi).
Le immagini di un sogno ci sembrano particolarmente adeguate ad approfondire proprio l’argomento di questo particolare sacrificio: all’inizio del sogno il sognatore ( un uomo maturo, nel pieno del suo percorso di individuazione) risale la corrente di un fiume fino alla sorgente, “proprio come i salmoni”; poi si trova all’interno di una immensa caverna primordiale, luminosa, immerso fino alle caviglie in un’acqua limpida e calma che ricopre il fondo. Con lui c’é sua madre, che ha un neonato in braccio, e lo protende, lo offre come in sacrificio ad un granchio colossale che sta di fronte: il granchio con la chela cava un occhio al neonato. Tutta l’operazione si svolge senza spargimento di sangue né turbamenti di altro genere.
L’etimologia aiuta nella comprensione del simbolo dell’occhio: orbo, dal latino orbum e dal greco orphanòs, non significa semplicemente “privo della vista”, ma in epoca classica indicava appunto l’orfano di padre, colui che era stato privato della vista, della visione del padre. I salmoni, com’è noto, ritornano nel luogo di origine percorrendo centinaia se non migliaia di chilometri al solo scopo di deporre le uova e poi morire, la loro capacità creativa è indissolubilmente legata al sacrificio di sé. Il sognatore, evidentemente di fronte ad una svolta cruciale della sua vita, sacrifica alla madre primordiale l’occhio/uovo, saldando il debito col materno: la sua nuova identità (il neonato) sarà l’orfano, il “privo del padre”.
Non può non venire in mente che il cristianesimo nasce proprio sull’esperienza dolorosa della perdita, dell’assenza della visione del padre, reiterata più volte dagli episodi chiave dei vangeli: prima dal grido dell’ultima disperata resistenza del Cristo alla trasformazione: “perché mi hai abbandonato?”. Poi dalla perdita della vita del Cristo, seguita dalla perdita del suo corpo, perdita talmente insostenibile per gli apostoli da dover essere stemperata da alcune apparizioni. L’episodio di Tommaso chiude la sequenza, con l’apostolo che resiste fino all’ultimo, continua a preferire la dipendenza dal padre reale, la vista oggettiva, la carne all’incarnazione, all’integrazione interiore: “tu hai creduto perché hai visto, beato chi crede senza vedere”. Questa l’indicazione del cristianesimo, religione sicuramente fra le più esperte in fatto di discendenza paterna.
Per trovare veramente se stessi, per “individuarsi”, cioè per trovare finalmente la realtà, lo “scopo” esistenziale, non è sufficiente recuperare il rapporto con l’universo simbolico della madre. È necessario anche “tornare dal padre” e, per poter fare ciò, bisogna arrendersi alla sua volontà, sacrificare totalmente la velleità dell’Io, accettare senza riserve la propria condizione di orfani: l’orbita vuota, ottenuta con il sacrificio dell’organo della vista oggettivante, della proiezione all’esterno, diventa allora l’organo della ricezione interiore, la ferita aperta sull’infinito attraverso la quale irrompe il trascendente che penetra nel profondo e “rivela” la vera identità individuale, “l’uomo nascosto nel fondo del cuore”.
Dice Von Balthasar: “Succede sempre di nuovo: non potere, lottare, ma invano, per arrivare a Dio; poi, quando si è stanchi, proprio allora, in questa stanchezza, in questo fallimento venire a sapere e sperimentare che Dio è in noi. La stanchezza come il “soffio” (...) in cui è Dio. Come potrebbe una debolezza essere un impedimento? Arrenditi dunque.”
Attraverso questa resa incondizionata che apre all’estremo la ricettività, l’individuo, come il figliol prodigo, “ritorna dal padre”, cioè entra in rapporto con l’universo simbolico del padre, e oltre, con la parola del padre che, come dicono le scritture, è “parola di verità e di vita”; rapporto che attiva nuove possibilit‡ di comportamento, atteggiamenti inediti, poco frequenti nella gamma delle modalità junghiane e hillmaniane, e totalmente assenti dalla natura: la preghiera, la compassione, la carità. Nel ritorno del figliol prodigo possiamo vedere questi comportamenti in atto: “... MíalzerÚ, e andrò da mio padre, e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non son più degno d’esser chiamato tuo figlio; trattami come uno dei tuoi garzoni. E, alzatosi, andò da suo padre. E mentre era ancora lontano, suo padre lo scorse e mosso a compassione, gli corse incontro e gli si gettò al collo e lo baciò...” La preghiera (intesa nel suo senso di oratio e non della paetitio), che scaturisce dalla coscienza del proprio essere carente, fa ritrovare al figlio la strada del ritorno. Ritorno che non è un semplice ripensamento, così come l’allontanamento non fu solo un errore, ma un processo di differenziazione necessario alla costituzione di una nuova e più ampia consapevolezza della propria responsabilità, della responsa, della risposta individuale alla proposta del padre. Padre che gli corre incontro, appena lo vede, da lontano, prima ancora di udire la preghiera; il ritorno del figlio è già la preghiera, è il segnale che, quasi in una sequenza di causa-effetto, provoca la compassione del padre, perché è il segno del sacrificio dell’Io, è il segno che l’Io è ora disposto all’abbraccio e all’unione col padre, è aperto all’irruzione dell’amore del padre, che era lì ad aspettarlo, che non aspettava altro che di poterlo amare. La preghiera è il nuovo atteggiamento che apre l’individuo alla relazione col padre, è un “inchinarsi” dell’Io che nasce, per così dire, quando tace l’anelito incessante dell’anima; la preghiera è la via che conduce a quel tempio interiore dove vertice e abisso coincidono, a quel luogo dove all’individuo si “rivela” l’orientamento fondamentale e più autentico della propria esistenza, la sua vera identità, “l’uomo nascosto nel fondo del cuore”. Dice S. Agostino: “L’uomo è il suo cuore, è il suo amore”.
La preghiera, come oratio, come offerta di sé, rappresenta un particolare atteggiamento simbolico che assicura la comunicazione col padre; i monaci ortodossi praticano una forma di preghiera continua, che consiste nella ripetizione incessante di una semplice frase, chiamata “preghiera del cuore”, una forma di relazione permanente.
Anche le immagini simboliche si trasformano rispetto alle espressioni meramente artistiche e culturali: l’arte sacra, la tradizione iconografica, che culmina nell’icona ortodossa, è una forma di rappresentazione che si sottrae sia alla mimesi dell’arte profana, cioè alla rappresentazione estetizzante della realtà, che tende complessivamente all’accentuazione del significante a detrimento del significato, sia alla scomposizione radicale della realtà, alla disperata ricerca del pre-formale dell’arte astratta, che tende al puro segno, illimitato, certo, ma irraggiungibile, avulso piuttosto che ulteriore. Dice Evdokimov: “La crisi attuale dell’arte non è estetica ma religiosa. Essa deriva da una perdita progressiva del senso del sacro e del suo simbolismo. (... non si tratta di raccontare la storia sacra, d’illustrarla, ma di attingere (attraverso l’immagine) il mistero del disegno di Dio; si tratta di scegliere tra il realismo naturalista, l’astrazione semiotica e il realismo simbolico dell’icona.”.
L’icona si oppone alla separazione di carne e spirito ed ha invece come unico obbiettivo l’incarnazione, l’evocazione della presenza, la partecipazione al mistero. Per Evdokimov “L'icona, col suo carattere sacramentale, rompe il triangolo (l’artista, la sua opera, gli spettatori, in cui si situa ogni opera puramente artistica) e il suo immanentismo. Essa si afferma indipendente dall’artista e dallo spettatore, e suscita non l’emozione ma l’avvento di un quarto elemento in rapporto al triangolo: l’avvento del trascendente, di cui attesta la presenza. (...) Fusione di principi artistici e religiosi ... l’icona è un punto di irruzione del trascendente” nell’immanenza della carne. L’icona vive di questa presenza, ma è il contrario di un idolo: rapisce lo sguardo ma non lo arresta, non lo imprigiona nell’oggetto, lo trasporta direttamente all’archetipo, svolgendo appieno la sua funzione simbolica: “Chi vede me vede il Padre”; nelle parole del Cristo si ribadisce la centralità dell’incarnazione come condizione della visione del Padre. “L’umano è afferrato nella sua funzione iconografica: immagine visibile dell’invisibile.
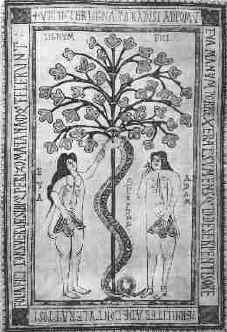
Carlo Alberto Cicali - Dario Squilloni
Centro Icone Fiesole (Fi)
Comunicazione tenuta nell’ambito del convegno "Il vertice e l'abisso"
Firenze 29-30 Ottobre 1994.