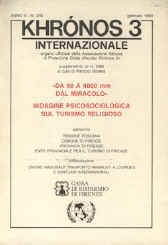
TURISMO RELIGIOSO: Esperienza di pellegrinaggio interiore
Antonio Tirinato
«E un vecchio sacerdote domandò: parlaci della religione. Ed egli rispose: oggi ho forse parlato d'altro? Religione e ogni azione e ogni riflessione, e una sorpresa, e uno stupore che eternamente sgorgano nell'anima, anche se le mani spaccano la pietra o tendono il telaio. Chi mai può separare la fede dell'uomo dai suoi atti e il suo credo dal suo lavoro? Chi può disporre delle sue ore, dicendo, "questa e per Dio e questa è per me; questa alla mia anima e questa al mio corpo?". Tutte le vostre ore, da l'uno all'altro, sono ali palpitanti nello spazio» 1.
Turismo religioso, una versione moderna del (vecchio) concetto del
pellegrinaggio che l'uomo compiva per recarsi nei luoghi a lui sacri.Il simbolismo,
rappresentato dal pellegrinaggio, corrisponde alla situazione dell'uomo sulla terra che si
sottopone ad una serie di prove per accedere, nel momento della morte, alla Terra
Promessa, al paradiso perduto, ad un regno in cui si giustifichi la sua esistenza.
Molti riti oggi vengono ripetuti senza più avere lo stesso significato, cioè, si sono
progressivamente impoveriti del loro senso profondo, spirituale, e sono diventati azioni
concrete di spostamento.
Il pellegrino, nel suo spostarsi, si muoveva in povertà e con questo voleva significare
il distacco e la purificazione dalla sua condizione profana; l'uomo era ancora disposto,
attraverso questo rito, ad ottenere una iniziazione pagando con il suo sacrificio.
Nella società attuale, i valori interiori si consumano in un opportunismo esteriore
sempre più vuoto di senso che proietta l'uomo nella assenza totale, provocandogli una
serie di sintomi da mancanza di spiritualità che si possono facilmente analizzare nei
comportamenti sociali.
I riti in genere, le religioni in particolare, non riescono più a soddisfare la richiesta
di spiritualità che vi è nell'uomo che, abbandonato, è costretto a compensarsi con
l'acquisizione di beni concreti che al contrario abbondano.
Possiamo dire, sul piano simbolico, che l'uomo di oggi è costretto a comprare invece che
a produrre.
Praticamente il sociale, diventato un «materno generoso», obbliga il figlio a non farsi
quelle domande che lo porterebbero ad allontanarsi dalla famiglia premurosa.
II tentativo continuo è quindi quello di togliere all'uomo la sua individualità, e di
renderlo collettivo e dipendente, e soprattutto di fargli dimenticare che tutto è dentro
di lui e che basterebbe trovare il tempo di ascoltarsi per scoprire la ricchezza e la
complessità del suo essere.
Il turismo religioso, in questo contesto, ridiventerebbe pellegrinaggio religioso e l'uomo
allora, rassicurato dalla sua civiltà tecnologica, potrebbe ripartire alla ricerca di
nuove mète spirituali; ma per il momento si deve accontentare di viaggiare verso luoghi
che hanno perduto la loro suggestione (e il loro fascino), che sono diventati monumenti ad
una spiritualità che fu e che non è più possibile rinnovare.
Quando il viaggio è turismo, qualsiasi monumento significativo va bene, ma quando il
viaggio è progressione spirituale allora solo cose che risvegliano l'immaginario
dell'uomo hanno valore.
In questo senso si può affermare che solamente quei viaggi che, oltre che concreti,
riescono a diventare anche interiori, hanno un valore religioso; dove il termine religioso
si deve intendere come il continuo tentativo dell'uomo di cercare e di scoprire un centro
interiore di spiritualità.
In tutta la mitologia e in tutte le letterature, il viaggio è sempre stato un'avventura
ed una ricerca dove, alternativamente un tesoro, un potere particolare oppure la donna
amata rappresentavano l'oggetto verso cui l'eroe mitico si dirigeva. In questa ricerca
egli avrebbe affrontato ardue prove dove poteva anche incontrare la morte, ma dalla quale
si sarebbe salvato con l'aiuto di un dio o di una dea.
In altre occasioni l'eroe poteva essere ingoiato da un mostro, che lo avrebbe isolato
simbolicamente nel proprio ventre fino al momento della sua fuga-rinascita; così è per
l'ingoiamento della balena, simbolico dell'ingresso nel periodo di oscurità intermedio
tra due stati o due modalità di esistenza 2. Mentre l'eroe è
chiuso all'interno, il mostro si mette di solito in viaggio verso Oriente, là dove sorge
il sole e dove l'eroe ritroverà la sua libertà; tema questo di rinnovamento tra il
periodo oscuro della mancanza di conoscenza e l'illuminazione.
L'uomo del ventesimo secolo affidandosi alla tecnologia ha conquistato
la Luna come satellite della Terra, ma l'ha perduta come dea della notte, guardiana delle
sue profondità inconsce.
Questo, non per essere nemici della scienza, ma per dire che non esiste un uomo che possa
fare a meno della immaginazione simbolica e del piano affettivo senza subirne gravi
conseguenze a livello di relazione sia con se stesso che con gli altri.
Così Eliade: «La vera scienza, quella trasmessa dai miti e dai simboli, è accessibile
soltanto nel corso o in seguito a un processo di rigenerazione spirituale realizzato dalla
morte e dalla resurrezione iniziatiche» 3.
Ogni vita umana, nella sua espressione autentica, implica crisi in profondità, prove
angosciose, perdita e riconquista dell'Io, morte e resurrezione.
Durante il periodo di crisi, si desidera ottenere un totale e definitivo rinnovamento, ma
questo si arena di fronte alla immagine della morte che, intesa nella cultura tecnologica
come fine, inibisce e vanifica la trasformazione.
Il terreno da cui trae nutrimento l'anima, dice Jung «è la vita naturale e chi non la
segue e si ribella alla propria fine, finisce per arrestarsi. Nel tentativo di non voler
morire si ottiene il risultato di non vivere» 4.
L'uomo si allontana dal suo naturale ciclo (della nascita, della crescita e della morte) e
le energie sono spese per vincere la morte (intesa come trasformazione) e non per capirla.
Così, egli, non potendone penetrare il mistero, si vede costretto ad interpretarla sul
piano simbolico. La morte diventa quell'avvenimento che introduce al mistero, ai mondi
sconosciuti e si configura come un rito di passaggio, cioè come una sequenza cerimoniale
che accompagna il 'passaggio' da una situazione all'altra o da un mondo (cosmico o
sociale) ad un altro 5. Tutte le iniziazioni attraversano una fase di morte
prima di aprire la via ad una vita nuova. La morte simbolica è quindi indispensabile
all'inizio della vita spirituale, essa prepara la nascita di un modo d'essere superiore.
Bisogna tagliare con il passato ed «uccidere l'esistenza profana», restaurare l'inizio,
«la pagina bianca della vita» dice Eliade 6.
Chiunque può partire per un viaggio, ma non per questo la comprensione è disponibile per
tutti: solo chi è consapevole del suo gesto è in grado di capire.
Come l'uomo pre-tecnologico affrontava le prove magiche per essere introdotto all'anima
del totem, cioè alla sua essenza spirituale, così l'uomo moderno deve affrontare
l'ansia e la solitudine come componenti fondamentali della lotta tra la sua essenza
profonda e i fantasmi collettivi e genitoriali che lo assediano.
In altre parole, quel disagio definito come «nevrosi dell'uomo moderno», è il richiamo
dell'anima del mondo dalla quale per vari motivi egli si è allontanato.
Il viaggio allora, più che dirigersi verso qualche luogo, si ricollegherà a quei
contenuti mitici e simbolici che vivono assopiti dentro gli individui; è per questa
ragione che non può e non deve essere solamente turismo, ma deve trasformarsi in
pellegrinaggio per restituire un senso profondo e compiuto all'esistenza stessa dell'uomo.
Note
1 - Gibran, 11 Profeta, Guanda, 1977, 109).
2 - Guénon, Considerazioni sulla via iniziatica, Basaia, 1982.
3 - Eliade, La nascita mistica, Morcelliana, 1956.
4 - Jung, Anima e morte, Boringhieri (1934), V. 8, 436.
5 - Gennep, 1 riti di passaggio, Boringhieri, I960.
6 - Eliade, Miti, sogni e misteri, Rusconi, I960.
Sta in:
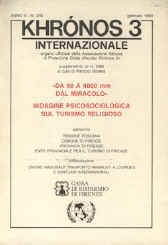
Khronos 3 - Internazionale Anno II - n. 2/s
Gennaio 1990